| Trattamento
Psicologico Indiretto in Età Evolutiva e Adolescenza |
|
|
Letizia Maduli
|
Premessa
Per trattamento psicologico indiretto si intende una
metodologia clinica utilizzata in psicologia senza la
presenza diretta del portatore del sintomo o del disturbo ma
con la presenza di almeno un familiare significativo.
In psicologia emotocognitiva le forme di trattamento
indiretto mirano a scardinare i processi di comunicazione e
comportamento ridondanti all'interno di un sistema di
riferimento che potrebbero essere alla base del mantenimento
di un sintomo, una psicopatologia, un problema. Le tecniche
di trattamento indiretto si sono rivelate le più efficaci
nella maggior parte dei casi di gravi disturbi di
personalità, dove la persona non riconosce pienamente
l'esistenza di un problema o comunque rifiuta una terapia
psicologica e nei casi di interventi in infanzia e
adolescenza.
In questa sede affronteremo l'applicazione delle forme
terapeutiche indirette rivolte all'età evolutiva.
L'intervento diretto su un bambino od un adolescente spesso
si rivela dannoso per il soggetto e potrebbe aggravare una
situazione psicopatologica anziché migliorarla. Nei nostri
studi capita spesso che problematiche di un bambino siano in
realtà da considerarsi iatrogene. A volte l'intervento di
cura sul minore è quindi uno dei responsabili del
mantenimento e dell'aggravamento della patologia quando si
tratta di disturbi o problematiche di natura psicologica.
L'intervento indiretto è efficace per quasi ogni forma
psicopatologica in età evolutiva, dal disturbo da deficit di
attenzione/iperattività (ADHD) ai tic, dai disturbi della
condotta alle problematiche di apprendimento, dall'ansia e
dalle fobie fino ai disturbi della nutrizione, nonché tutte
le problematiche legate all'attività scolastica.
In altri contesti clinici, soprattutto di tipo
medico-psichiatrico, si sta assistendo ad un abbassamento
dell'età in cui vengono somministrati farmaci. La
somministrazione di uno psicofarmaco, stando alla nostra
casistica clinica, si è rivelata una delle forme più gravi
di mantenimento della maggior parte delle sintomatologie,
sia in età adulta che, soprattutto, in età evolutiva. Un
bambino che viene considerato malato si comporterà da
malato. Nella maggior parte dei casi gli interventi
psicologici in età evolutiva, in assenza di condizioni
mediche generali in grado di giustificare una
sintomatologia, permettono oggi la remissione di quasi ogni
forma psicopatologica, senza uso di farmaci e soprattutto
senza inserire un bambino od un adolescente in un contesto
di cura.
I trattamenti psicologici indiretti rispondono inoltre ad
un'esigenza fondamentale che i familiari di un minore che
evidenzia delle problematiche hanno, quello di fornire
strategie di comunicazione e di comportamento per poter
rispondere in modo adeguato a situazioni che, nella maggior
parte dei casi, sfuggono dal controllo e dalle proprie
capacità di intervento. I genitori si sentono spesso
impotenti di fronte ad un problema e chiedono costantemente
cosa possono fare per aiutare il proprio figlio, come si
possono comportare.
Molti genitori che si rivolgono presso i nostri studi di
psicologia emotocognitiva dichiarano di essersi già rivolti
ad istituti di neuropsichiatria però senza ottenere un
successo terapeutico e, soprattutto, dichiarano che alcuni
professionisti della salute colpevolizzano i genitori.
Ricordiamo che un genitore che desidera la salute del
proprio figlio agisce sempre nel giusto. Di fronte ad un
problema, però, non è importante se l'azione sia giusta o
sbagliata, ciò che importa allo psicologo è se il tipo di
comunicazione ed il tipo di comportamento abbiano
funzionato, questo perché quando un atteggiamento od una
cura non funzionano abbiamo riscontrato che in realtà
possono peggiorare la situazione.
Oggi esiste quindi una nuova possibilità efficace di terapia
in età evolutiva e adolescenza che mira a scardinare il loop
disfunzionale che sostiene un sintomo, un disturbo mentale
od una problematica psicologica o psico-sociale ed è il
trattamento psicologico indiretto.
Terapia Indiretta in Età
Evolutiva e Adolescenza
L’intervento psicologico di tipo indiretto può essere
considerato lo strumento clinico di riferimento principale
nella terapia, attraverso il colloquio psicologico, di sintomatologie, disturbi mentali,
disagi e problematiche dell’area evolutiva.
Il trattamento indiretto, nell’infanzia e nell’adolescenza,
è un tipo di intervento psicologico che prevede solo il
coinvolgimento di uno o più membri adulti significativi
della famiglia, i quali rappresentano la risorsa principale
per un agire un cambiamento, in genere in tempi molto brevi,
e per ripristinare una situazione di benessere del minore e
contemporaneamente tutto il sistema familiare.
[ARTICOLO FULL TEXT IN ARCHIVIO]
Questo articolo è attualmente in
archivio e sarà disponibile
nell'Antologia Psyreview Articoli dal 1999 al 2019
PUBBLICAZIONE PREVISTA PER MARZO 2024
20 ANNI DI ARTICOLI DI SCIENZE PSICOLOGICHE
PSYREVIEW EDIZIONI
consiglia
"Diagnosi e
Trattamento del Disturbo Borderline di Personalità"
del Dott. Marco Baranello
Novità
Editoriale 2023
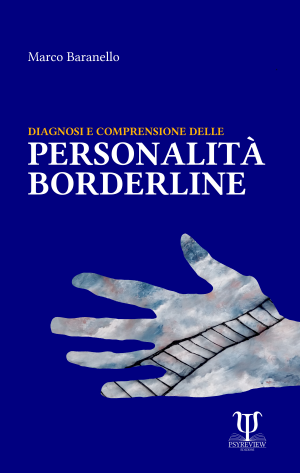
DISPONIBILE SU AMAZON LIBRI
SCOPRI DI PIU'
il disturbo borderline di
personalità affrontato in modo chiaro e dettagliato, un approccio pragmatico sia
per professionisti e studenti di scienze della salute sia per coloro che
desiderano approfondire la tematica
|